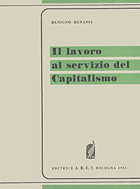Parte prima
 |
 |
Nel mondo delle idee
Capitalismo o Capitalite?
Chissà mai se si potrà riuscire a chiarificare le idee. Senza dubbio «Capitalismo» è parola che fa venire i calcoli al fegato a tutti coloro la cui esistenza è malauguratamente legata al Capitale altrui. Dire «Capitalismo» è oggi dire «Sfruttamento». Ad esser però leali s'arriva a comprendere che il Capitalismo in se stesso significa soltanto impiego di un Capitale; e Capitale è per definizione la somma dei risparmi di uno o più individui. Impiegare tale somma di risparmi per far sorgere una fabbrica, per esempio, che dia lavoro a chi ne ha bisogno, questo è un far produrre il Capitale, è cioè un atto capitalistico. E non è certo una cosa cattiva. Allo stato attuale poi della tecnica umana pare sia una cosa addirittura necessaria. Tanto è vero che non c'è società al mondo, anonima o privata o statale, che non si serva del Capitale.
Ad esprimere pertanto l'idea che specialmente i più poveri e i più sfruttati legano alla parola «Capitalismo» si dovrebbe dire piuttosto «Capitalite», che significherà una malattia del Capitale, una infiammazione del Capitale. Così come la peritonite è una infiammazione del peritoneo. E qui si tocca il nocciolo del problema: il Capitalismo è un frutto inevitabile della industrializzazione moderna; la Capitalite è una maniera errata ed ingiusta di adoperare il Capitale.
Il Capitalismo privato, poi, nella sua realizzazione ingiusta, ha provocata una reazione uguale e contraria: il Capitalismo di Stato, cioè a dire il Comunismo. È infatti inutile giocar sulle parole per distinguere in destra e sinistra il Capitalismo ed il Comunismo, quasi si trattasse di due cose indipendenti e contraddittorie. Tra il Capitalismo (e intendo l'applicazione errata ed ingiusta dell'impiego del Capitale privato) e il Comunismo c'è una relazione di causa ad effetto, di padre a figlio. E il bello (che è poi brutto) si è che il Capitalismo di Stato, cioè il Comunismo, è anch'esso una Capitalite. Hanno un bel raccontare sulle piazze che il Comunismo sopprime il Capitale privato ed elimina quindi coloro che vivono del lavoro degli altri. È elementare verità che la trasposizione della proprietà produttrice nelle mani dello Stato non conduce alla soppressione di tutta una classe di individui i quali vivono delle rendite di tali proprietà. E di fatti il regime in Russia, p. es., ha bisogno della costituzione di una nuova classe la quale ha, per così dire, autorità nello Stato per stabilire i piani di lavoro e di produzione; classe che si pone al di sopra dei lavoratori diretti, proprio come i signori nel Capitalismo privato. Tale classe in Russia è in realtà la nuova sfruttatrice la quale vive sulla produzione nazionale. Così elementare ed evidente è la corrispondenza tra i due sfruttatori (padrone-funzionario) che, se la si vuol esprimere in termini commerciali di danaro, si constata che la rendita (paga) del funzionario sovietico non è meno alta di quella dell'industriale medio americano.
Dal punto di vista della giustizia (ingiustizia) umana poco importa che il lavoratore sia costretto a spremersi per ingrassare un cittadino privato od un funzionario pubblico. La realtà nuda e cruda è identica: il lavoratore è sfruttato.
A dire dunque tutta la verità, l'atto di accusa che i lavoratori sfruttati hanno diritto di formulare non deve essere lanciato contro il Capitalismo ma contro i Capitalisti. Più esattamente contro quei Capitalisti, privati o di Stato, i quali adoperano il Capitale per vivere alle spalle degli altri.
Il Capitalismo è un'arma a doppio taglio. A bene impiegarla e secondo giustizia è cosa buona. Ad adoperarla male è una disgrazia sociale. Né il Capitalismo è un partito: esso è un sistema di produzione che può essere (come lo è infatti) attuato in qualunque Governo, sotto la direzione di qualunque Partito. Il Capitalismo pertanto non è la stessa cosa che gli Stati così detti Capitalistici: esso è un sistema legato al progresso della civiltà umana. La questione del Capitalismo, nei suoi valori umani, si pone dunque come una questione sul modo di impiegare il Capitale. E il modo di impiegare il Capitale dipende dal modo con cui si concepisce l’UOMO. Ci si addentra cioè in un problema di base che è il denominatore comune di tutti i sistemi sociali-economici. In un altro fascicoletto esponevo le attuazioni pratiche del Comunismo nel campo del lavoro. La mia conclusione era che il Comunismo, in quanto istanza sociale, si riduce allo sfruttamento della «massa» per la comodità dei furbi, più precisamente dei capi. Anche in esso dunque c'è alla base una frattura della umanità, una distinzione fra uomo e uomo. Le parole sono di uguaglianza, si sa; ma cosa contano le parole di fronte ai fatti sistematici e legalizzati?
Il Capitale ladro
È senza dubbio di basilare importanza, in un discorso sul Capitalismo, dar chiara l'idea di cosa sia il Capitale. Il Capitalismo infatti è un regime economico ove il Capitale gioca un ruolo preponderante, e ove la funzione capitalistica si separa dalla funzione di lavoro.
Il Capitale è «la ricchezza conservata», in opposizione a «la ricchezza consumata» a misura che viene acquistata. I beni immobili sono un Capitale: le terre, per esempio, i fabbricati. Che se io presto a Tonio la bellezza di 500.000 lire a interesse, quelle 500.000 lire sono un Capitale. Il danaro nelle sue varie forme (biglietti bancari, chèques ecc.) è un Capitale: un capitale mobile.
Per bene capire la nozione di Capitale quale la intendono i marxisti bisogna riferirsi a questa ultima categoria: il danaro. Il vero Capitale messo in causa dai marxisti è quello che essi chiamano «capitale variabile». Questo capitale ha una tal quale relazione con le buste-paga dovute ai lavoratori; relazione di qualità poiché si tratta di danaro liquido, e relazione di origine, poiché esso si produce all'occasione della paga agli operai. Questo «Capitale variabile» è di derivazione ladra poiché esso è costituito dalla somma continuata di frazioni di paghe dovute agli operai e invece ritenute. Nella ipotesi che il padrone dia all'operaio lire 950 al mese invece delle 1000 dovute, nel giro di un anno il padrone avrà rubato all'operaio lire 600. Se gli operai saranno 2.000, nel giro di soli 5 anni il padrone avrà messo insieme un capitale variabile rubato di 6.000.000.
La iniquità di un tale procedimento non v'è chi non la veda: nessuno mai ha preteso di giustificarlo. Gli è che i marxisti si muovono in un dinamismo di idee che è sconcertante; l'ipotesi, ben possibile d'altronde in taluni casi determinati, è per essi una realtà sacrosanta. Non solo: ma tutti i capitali si sono fatti così. Affermazione categorica e sistematica che non vale la pena di sottoporre a discussione tanto evidente ne è la ingiustizia e la falsità. Basti osservare, del resto, che essa si porta su tutti i capitali passati, presenti e futuri. Ora, almeno i capitali che si formeranno in futuro hanno il diritto di non essere giudicati prima che si siano realmente formati.
D’altra parte i Comunisti stessi, come dimostrai nel citato fascicolo sul lavoro al servizio del Comunismo (p. 105), covano stridenti disparità salariali, disparità che sono alla origine delle differenze economiche fra i salariati, alcuni dei quali — aiutati anche dalla buona sorte — riusciranno a mettere da parte alcuni risparmi che potranno, col tempo, diventare anche base di un capitale da investire in nuove imprese di lavoro. Gli altri invece, perseguitati forse anche dalla sfortuna, resteranno perennemente nel rango dei lavoratori assillati dal bisogno.
Resta comunque chiaro che, presentato così il Capitale, ogni capitale, la rivolta del lavoratore è bene alimentata: il lavoratore si ribella contro colui che gli ha rubata una parte del suo stipendio. È così che il Capitalismo, nella mente semplice, credula e un tantino (!) interessata del lavoratore marxista rappresenta «l'insieme degli inconvenienti e degli abusi del regime moderno». A ben riflettere mi par che stia in queste idee-forza tutto il fascino del comunismo marxista in seno alle masse lavoratrici. Non è la promessa di dare la terra, in quanto dono, ai contadini, o la fabbrica (e gli utili), in quanto dono, agli operai, ma è il presentar tali arrivi come tappe di giustizia retributiva. Il contadino marxista impara a dire «la terra che io lavoro è mia» e l'operaio la fabbrica. La ingenua apposizione del possessivo «mia» è una logica conseguenza della nozione data di «capitale variante», applicato poi al capitale in genere.
Sicuro che a voler farsi amare dai poveri, che sono anch'essi egoisti, quella presentazione del capitalismo è mezzo utilissimo: non è leale, però, perché falsa. Il Capitale, ogni capitale, risponde alla idea di «ricchezza conservata», e non ogni ricchezza conservata è necessariamente una ricchezza costituita dall'accumularsi di furterelli successivi. Più di un caso si conosce di lavoratori, di salariati i quali economizzano sullo stipendio e aiutati dalla fortuna hanno potuto metter da parte una discreta somma e investirla successivamente in azioni capitalistiche. Il capitale dunque non è cosa necessariamente ingiusta od ingiustamente formata. Pertanto il Capitalismo, inteso esattamente come un impiego del capitale nella produzione, non è affatto l'insieme degli inconvenienti e degli abusi del regime moderno. Storicamente lo è stato; ma per il modo con cui è stato attuato. Tali inconvenienti ed abusi esistono spesso in realtà in regime capitalistico (e qui ricordo che per tale aspetto anche il Comunismo è capitalista), ma non sono un frutto necessario del Capitale, sì bene son conseguenza macabra di un modo egoista d'impiegare il capitale. Il fatto che tanti, troppi certamente, si servano del capitale per rubare, non mette sotto accusa il capitale stesso ma soltanto coloro che rubano. Così come Tonio, il mio simpatico amico Tonio, non può affermare che tutte le medicine sono dannose, né che tale medicina lo è, per il fatto che lui s'è quasi avvelenato usandone a sproposito. Il capitale è come una medicina: ad adoperarla bene salva dalla miseria, ad adoperarla male uccide. Non perché essa può uccidere, se male adoperata, la si deve condannare o gettare. Bisogna soltanto usarla bene. Così del capitale.
Capitalismo e Liberalismo
Il Capitalismo è un sistema economico nel quale il capitale, gli strumenti di produzione e la relativa organizzazione appartengono a persone che non sono coloro che tali mezzi fanno produrre per mezzo del loro lavoro.
Di fatto pratico il Capitalismo fa corpo unico col Liberalismo. Il quale ne sarebbe il motore, la dinamica ideologica.
È forse utile un chiarimento ancora. Ci sono, specialmente in Italia, tanti liberali che del liberalismo portano soltanto il nome o quasi.
Il Liberalismo tuttavia è un sistema politico-sociale ben determinato: esso è la causa fondamentale del mal uso del Capitale, in quanto esso è la negazione di ogni legge superiore che impegni tutti gli uomini. Il Liberalismo è «un sistema politico e sociale, secondo cui l'elemento civile e sociale non si rileva che dall'ordine umano e può o deve essere attuato ed agire senza alcuna relazione obbligatoria di dipendenza dall'ordine soprannaturale». Esso considera come propri principi dinamici e direttivi nella vita economica il guadagno e la libera concorrenza. Tale liberalismo si chiamò «naturalismo politico puro» e fu il materialismo piatto del secolo XVIII; si chiamò «naturalismo politico mitigato» e fu la successiva relegazione pratica del sovrannaturale nell'ambito della vita privata. C'è senza dubbio una scala di valori nelle diverse manifestazioni del liberalismo: resta però un elemento comune, ed è la pratica esclusione dell'elemento morale-universale ed eterno dalla vita sociale. Nel 1887 i prelati della provincia di Burgos (Spagna) scrivevano nella loro lettera collettiva: «Il naturalismo... che lo si chiami razionalismo, socialismo, rivoluzione o liberalismo, per la maniera d’essere e per la sua essenza medesima sarà sempre la negazione franca o artificiosa, ma radicale, della fede cristiana».
Da una simile dottrina è necessario che ne derivi una cattiva applicazione del Capitale nel sistema della produzione. In termini chiari la libertà vera (quindi in tutti i campi), che è anche giustizia sociale, suppone la uguaglianza giuridica di tutti gli uomini. Ora il liberalismo ha ucciso il padre (Dio) in cui solo si fonda la uguaglianza della fraternità umana. Come è possibile senza la unicità della sorgente parlare di fraternità e di uguaglianza?
Sulla universale figliolanza da Dio ben si costruisce l'edificio di una legge uguale per tutti: ma, scardinata la base, non si vede come si possa impedire alla forza di occupare i seggi della giustizia. Il milionario che adopera un milione che è suo, per il mantenimento di una intera collezione di cani, non è perseguibile dalla legge umana anche se nella casa vicina ci sono dei bimbi che muoiono di fame; nessuno però potrà negare che tale sciupio sia un attentato alla società. La pura legge umana, avulsa dalla sua giustificante divina, nulla può contro quel milionario. I fratelli però che stentano la vita accanto a lui, nella medesima barca della società, quei fratelli sanno che quell'atto è un crimine.
Quasi quasi ci si sente portati ad affermare che il ladro che ruba sfacciatamente è preferibile ad un tale milionario. Non solo perché la legge può intervenire contro di lui, ma specialmente perché il ladro di professione (!) è almeno franco nel male agire, mentre lui, lo scialacquatore, legalizza, in nome della dignità della persona umana che calpesta, il suo abominevole attentato sociale.
Sguardo a l'indietro
In una pur rapida visione del Liberalcapitalismo ci sono taluni nomi che non si possono tralasciare. Ricerca di soluzione sociale scattata dall'urgenza del problema agricolo con Quesnay (1694-1774), Gournay (1712-1759), Turgot (1727-1781) e riapplicata euforicamente alla industria nascente da Smith (1723-1790), Bentham (1749-1832), Gian Battista Say (1767-1832), Bastiat (1801-1850) e Romagnosi e Scialoia e Ferrara; e poi riesaminata con pauroso pessimismo egoista da Malthus (1766-1836) e da Stuart Mill (1806-1873) come già in parte da Riccardo David (1772-1823).
Nei tempi moderni la ricerca si è, pare, incanalata nelle due scuole: Scuola Matematica, Scuola Psicologica. I fautori della prima, detta anche Scuola di Losanna, pongono il problema delle relazioni di lavoro nei termini facili di un equilibrio proprio alle equazioni matematiche (Walras 1883, Barone 1913, De Pietri-Tonelli 1919, Amoroso 1942). Gli Psicologisti s'attardano sul concetto di valore, in economia, limitandolo poi ad una espressione commerciale dei desideri dell'uomo. Riducono pertanto lo studio del problema economico allo studio psicologico dei desideri umani e delle loro cause (Menger 1871, Jevons 1871, Bohm-Baverk 1921, Pantaleoni 1931). ![]()
Il denominatore comune di questo umanesimo antiumano, perché solo umano, si riassume in uno sterile dottrinarismo il quale riduce i rapporti umani, gli economici tra i primi, ad un dialogare sulla utilità dell'individuo dissaldata da ogni legge morale e animata dalla dinamica vivacissima della concorrenza delle forze materiali. A lasciarsi prender la mano dal concatenarsi delle conseguenze s'arriva inevitabilmente ad una accettazione determinata di leggi naturali nel campo puramente economico. «Lasciamo che gli uomini lavorino, che si scambino i loro prodotti, che agiscano e reagiscano gli uni sugli altri, poiché secondo i decreti provvidenziali, non potrà dalla loro intelligente spontaneità che pullulare l'ordine, l'armonia, il progresso, il bene, il meglio, il meglio e ancora il meglio fino all'infinito». ![]()
Gli investimenti del Capitale sono spinti dal miraggio spasmodicamente bramato del massimo vantaggio col minimo mezzo, il tutto crismato e santificato dal feticcio della libera concorrenza. La quale cosa si traduce con parola sincera e di facile comprensione: egoismo. «Fare liberamente e spontaneamente il proprio interesse e ci si troverà in perfetto accordo col pubblico bene e con la legge morale». Vaneggiamento infantile che cerca una giustificazione filosofica ne l'affermare che l'utilità comune è risultanza delle somme delle utilità di ognuno. Ove si sente, sotto le ingenue parole comunitarie, e teoricamente vere, la desolata solitudine dell'uomo, dimentico che la vita sociale impone dei limiti ai desideri dei singoli, limiti determinati dall'antagonismo degli interessi.
L'uomo nel regno del Liberalcapitalismo
«Luigi — mi disse papà — vieni a mietere il grano. Tuo fratello ha risposto di no. E tu?».
«Vengo, papà» gli risposi. Ma non ci andai.
Si può dunque negare obbedienza al proprio padre anche se a parole si risponde di sì.
Beh, per la concezione dell'uomo è un po’ la stessa cosa. Il Comunismo afferma che l'uomo individuo deve scomparire di fronte alla società. Gli Stati Capitalistici esaltano invece la persona umana. Gli è che, se si cercano i frutti, ci s'accorge che la persona umana è schiacciata. In realtà quegli Stati Capitalistici che attuano la Capitalite (tanto per intenderci), esaltano la persona umana nella teoria; nella pratica però la distruggono fratturando essi pure l'unità della umanità. Non c'è uomo di buon senso il quale non veda che non è un esaltare la persona umana il legalizzare la esistenza di crapuloni che vivono sulle rendite del loro capitale messo a produrre con le braccia di altri uomini i quali non hanno danaro a sufficienza per vivere col decoro dovuto alla persona umana.
Un uomo vale l'altro, ed esaltare la persona umana deve equivalere ad esaltare tutti e singoli gli uomini. Il Padrone Tonino non è affatto più uomo dell'operaio Renzo. Se dunque il padrone Tonino oserà sfruttare l'operaio Renzo, e se tale sfruttamento sarà legalizzato dallo Stato, ecco, in tal caso, il padrone Tonino ed i capi che lo legalizzano fratturano l'umanità. Da un lato la élite dei padroni cui la fortuna, la salute e spesso il furto hanno permesso di accumulare un forte risparmio, e dall'altro la massa innumerevole del «popolo» cui la miseria dello stipendio, la incapacità, le malattie, le disgrazie e talvolta il vizio hanno impedito di accumulare dei risparmi. E i padroni credono di poter dire di difendere la persona umana allorché bivaccano con le amanti in festini lussuosissimi di fronte alla indigenza dei lavoratori nelle cui mani il loro capitale è diventato fruttificante. In realtà però non la dignità della persona umana essi difendono, sibbene il signor Tonino e soci, e ne difendono la dignità della persona a scapito della dignità della persona di migliaia e migliaia di altre persone umane che soffrono.
Vien qui la domanda fondamentale: ma di dove trae la sua forza viva e reale l'unità della umanità? La risposta è facile: l'unità della umanità è conseguenza logica della filiazione divina dell'uomo. Se l'uomo è creatura di Dio allora tutti gli uomini sono uguali nei diritti e nei doveri. Che se l'uomo è lui il re assoluto della vita, allora i diritti ed i doveri saranno nella proporzione della forza di ognuno.
Il laicismo anima del Liberalcapitalismo
Alla base degli stati capitalistici tali quali esistono oggi ci sta il laicismo. Il quale non è quella certa medicina che Pierino addita come salvezza dal Clericalismo. Nulla credo di più decisivo che lasciare la parola agli esponenti del laicismo europeo. Apriamo dunque il Dizionario dell'Accademia Francese 1931 e cerchiamo. (N. B. La scelta della Francia è logica: essa fu il primo paese in cui il laicismo si organizzò in termini statali).
Il Dizionario dice così:
«Laicizzazione: azione di laicizzare, risultato di tale azione.
Laicizzare: sostituire il personale religioso di un istituto di insegnamento o d'assistenza con personale laico.
Laicismo: dottrina che tende a riservare ai laici una data parte del governo della Chiesa. Si dice particolarmente della dottrina che tende a dare alle istituzioni un carattere non religioso.
Laicità: carattere di neutralità religiosa di uno stabilimento di istruzione o d'assistenza, di una legge, di una istituzione.
Laico:... significa anche colui che è estraneo ad ogni confessione o dottrina religiosa. Insegnamento laico. Scuola laica. Per estensione, Stato laico, leggi laiche, cerimonie laiche».
A ben capire il valore di tali affermazioni ci aiuta Ernest Levisse che (cfr. Annales de la Jeunesse laique 1 (1902) 1) scriveva: «Essere laico non è limitare il pensiero umano a l'orizzonte visibile, e neanche interdire all'uomo il sogno e la perpetua ricerca di Dio, ma sibbene rivendicare per la vita presente lo sforzo del dovere.
Essere laico non è violentare, non è disprezzare le coscienze ancora irretite nelle catene delle vecchie credenze, ma è rifiutare alle religioni che passano il diritto di governare l'umanità che dura.
Esser laico non è odiare tale o tal'altra Chiesa o tutte le Chiese insieme, ma è combattere il soffio di odio che spira dalle religioni e che fu causa di tante violenze, di massacri e di rovine. Essere laico è non consentire affatto la sottomissione della ragione al dogma immutabile né l'abdicazione dello spirito umano davanti a l'incomprensibile, ma è non prendere partito di alcuna ignoranza. Essere laico è aver la ferma convinzione che la vita vale la pena d'essere vissuta, è amare questa vita, è rifiutare la definizione della terra 'valle di lacrime', è non ammettere che le lacrime siano necessarie e facciano bene né che il dolore sia provvidenziale; è insomma non prendere partito di nessuna miseria. Esser laico è non rimettere ad un giudice che segga nell'al di là, la preoccupazione di sfamare chi è affamato e di dissetare chi ha sete e di riparare le ingiustizie e di consolare coloro che piangono: è dichiarare guerra al male in nome della giustizia. Esser laico è avere tre virtù: la carità, cioè l'amore degli uomini; la speranza, cioè il benefico sentimento che giorno verrà, nella posterità lontana, in cui si realizzeranno i sogni di giustizia, di pace e di felicità che un tempo i nostri avi facevano guardando verso il cielo; la fede, cioè la volontà di credere alla realtà vittoriosa dello sforzo perpetuo».
Che se tali parole non bastano a illuminare il quadro del mondo laico, ci si può ancora riferire a quanto Etber (cfr. Editions des Annales de la J. L., p. 11) pronunciò al 2° Congresso della Gioventù Laica, a Parigi nel 1904:
«La rivoluzione è più che una data storica, cosi come la Repubblica è altra cosa che un regime politico. L'una e l'altra sono un atto di fede nella natura umana. L'una e l'altra professano che la società ha in se stessa la sua ragion d'essere, la sua grandezza ed il suo fine, poiché entrambe proclamano l'autonomia della coscienza umana. Né Dio né padrone, questa formula di liberazione integrale, noi la troviamo tutta intera nella Rivoluzione integrale. La Rivoluzione è l'uomo reso alla libera disposizione di se stesso. La Rivoluzione è la società arbitra dei suoi destini. Noi siamo figli della Rivoluzione».
Dio dunque viene messo da parte. È l'uomo che, a parole, viene esaltato. Lucien Victor-Meunier (cfr. AJL 9 (1910) 296) parodiava il Credo degli Apostoli cominciando così: «Io credo nell'uomo onnipotente, signore del cielo e della terra...». E già nel 1901 l'ex prete Charbonnel (Gennaio 1901) fondava il settimanale 'La RagionÈ e scriveva: «L'irreligione latente ed inerte non ci basta; noi vogliamo che essa sia attiva, battagliera, instancabile... Perché noi non possiamo avere speranza nella nuova società di gioia di libertà e di bellezza se non quando la Chiesa sarà definitivamente annientata».
Son questi gli urlamenti umani, in nome della umanità, per ridurla orfana. Più o meno tutti gli Stati (anche il Comunismo, ove governa, la realizza) a regime capitalistico sono imbevuti, negli uomini che governano, di questa mentalità: liberare l'uomo dalla schiavitù di Dio per dargli una vita di gioia e di bellezza. Non è compito mio esaminare se gli uomini che furono alla origine del movimento furono in buona fede: certo — la storia lo ha abbondantemente dimostrato — le loro teorie applicate hanno cambiata la vecchia «valle di lacrime» in un modernissimo e grande «cimitero».
La identità di natura tra Capitalismo (= Capitalite) e Comunismo la si scopre bene sul piano del laicismo. Sono essi avversari ma sono entrambi prodotti dal medesimo spirito di rivolta. E qui si tocca il Capitalismo applicato da un dato Governo. Bisogna però tener sempre presente che la base che animò la sua organizzazione politica fu il laicismo del quale lo sfruttamento economico fu logica derivazione. Il nome politico del laicismo fu Liberalismo. Chi ha abitudine alla Storia religiosa del secolo passato, ben ricorda il Liberalismo biblico cominciato già verso il 1733 col nome di Aston; Reimarus, Voltaire e poi cento e cento altri. Fu un assalto vero e proprio alla divinità. E gli assalitori si organizzarono in partito per meglio difendere e diffondere le loro idee. Avemmo cosi il Liberalismo. Attenti però a non confondere i Liberali d'oggi, almeno in Italia, coi Liberali d'allora. Molta acqua è passata sotto i ponti della storia e oggi più di una vecchia utopia è caduta lasciando amara la bocca a chi volle sostituire l'uomo a Dio. Quel Liberalismo (in Francia Radical-Socialismo) d'allora instaurò dunque un sistema di produzione (per quanto ci interessa direttamente) basato sulla assenza assoluta di Dio. Mica si doveva fare fatica a capire che, eliminato Dio, svaniva il concetto di morale costante e valevole per tutti. La parola giustizia si spense della sua radiazione reale e divenne eufemismo di furto, carità significò egoismo, libertà volle dire licenza.
Io credo che voler giudicare il Liberalcapitalismo nel campo economico senza tener conto di questa base atea significhi privare il Liberalismo del suo principale motore.
Il risultato del Liberalcapitalismo, sul piano economico-sociale, fu del tutto diverso da quello promesso. La tecnica applicata all'orgoglio del superuomo ha distrutto l'uomo per creare la «massa». E la «massa» è, per definizione, equivalente di spersonalizzazione. È interessante notarlo: la spersonalizzazione dell'uomo non fu mai così attuale come quando se ne celebrò la divinizzazione. Ciò che fa la personalità umana è infatti la ponderatezza e la originalità dei suoi giudizi; la persona umana si determina nella arditezza del suo pensiero che equilibra le sue passioni concludendo ad un predominio del libero arbitrio. Si può dire anche che la persona umana vive della sua vita interiore. Tale interiorità della vita fu uccisa proprio con la abolizione di Dio. Del resto la implacabile logica dell'egoismo umano, che cercava la gioia, nel campo della produzione spinse l'uomo capitalista alla ricerca del sempre più e del sempre meglio. Sulle tettoie armoniose delle officine passò lugubre l'urlo egoista: tutto il capitale è mio, dunque il vantaggio sia tutto mio. E il lavoratore fu costretto, dalla logica delle sue stesse convinzioni ubriache, ad esser contento del minimo indispensabile per non morire. I documenti ed i fatti non è necessario trascriverli: ancora oggi è una realtà troppo vivente nei nostri Stati a regime liberalcapitalista.
Il primato del piacere raccontato come lo scopo supremo ed unico della vita, conduce inevitabilmente all'egoismo. L'uomo della massa, così come l'uomo padrone, finisce per ripiegarsi su se stesso e per valutare ogni cosa in relazione commerciale. Il piacere come scopo unico della vita si traduce in oppressione del più forte sul più debole nel campo sociale-economico-politico. La sua prima conseguenza è quella di creare compartimenti stagni nella società ove si battezza per legge giusta la legge della giungla: il debole deve soccombere di fronte al più forte.
L'errore liberalcapitalista sta proprio nell'aver legittimato il furto della persona del lavoratore. Se l'Internazionale esagera quando canta la liberazione del proletario «condannato della terra», non si può tuttavia negare che a suggerire queste parole sta un fatto umiliante: il lavoratore è considerato come una cosa qualunque, una mercé da acquistare e da consumare per il proprio piacere. Il lavoratore fu ridotto, dalla codificata ricerca ultima del piacere sempre più grande, ad una ruota di un macchinismo spaventoso destinato a sfornare pane sì e no per chi lavora, e biglietti da mille per chi si diverte. Non è compito mio dare un giudizio morale sui fatti: io constato. Sotto il nome della libera concorrenza si nascondeva l'attentato ai meno agguerriti; e i padroni divennero sempre più ricchi a scapito di un innumerevole stuolo di piccoli padroni che furono ridotti a semplici prestatori d'opera. La libertà della persona umana fu l'equivoco altare in cui il liberalcapitalismo incensò ai lucri favolosi di alcuni pochi favoriti dalla sorte, dall'astuzia e sovente dal furto.
La Capitalite è tutto questo: è la forma economica del liberalismo filosofìco. È la trasposizione dell'ateismo nei rapporti del lavoro. E qui ci si trova ancora a contatto con stessa natura del Comunismo.
La Capitalite, dicevo, è l'applicazione falsa ed ingiusta dell'impiego del Capitale nella produzione. Proprio perché in se stesso l'impiego del Capitale nel gioco della produzione non è cosa cattiva, appare più chiaro che il Capitalismo tale e quale lo intendono oggi i lavoratori, è frutto di una contaminazione dell'uomo. Non dunque il Capitalismo è da mettere sotto accusa, sì bene quelli che se ne sono serviti male. È precisamente per correre alla radice del male che io mi sono rivolto a cercare le cause dell'impiego ingiusto del Capitale.
L'astuzia diabolica dei Capitalisti
I Capitalisti ( = Liberalcapitalisti = Laicocapitalisti) per giustificare il loro crimine sono ricorsi alla negazione di Dio. Se l'uomo è il re assoluto del mondo, l'uomo può cercare con tutti i mezzi il suo piacere. Attenti però a non essere ingenui. I Liberalcapitalisti negano Dio, ma affermano la esistenza di Dio. È un fenomeno contraddittorio a prima vista; ma a studiarlo profondamente si rivela una macchinazione astutissima. Tutti i mezzi sono buoni al proprio piacere: anche proclamare la esistenza di Dio. Quando io leggo nelle reazioni furiose di Lenin (cfr. Sulla Religione, Ed. Rinascita, Roma 1945, p. 20) che «la religione è l'oppio dei popoli», che «la religione è una droga per meglio tenere soggetti i lavoratori», io sento che Lenin non ha tutti i torti. Il suo torto è solo quello di avere identificata la Religione con quella specie di religione ad uso dei padroni. È del resto vergognosamente vero che tanti padroni si sono proclamati credenti pur di potersi servire della religione per i loro scopi egoisti. Lenin è soltanto inesatto; se la sua frase la correggiamo così: «La religione che vivono taluni padroni è l'oppio dei popoli», quella frase la firmerei anch'io almeno nell’80 % dei casi.
In questa cornice devonsi intendere gli episodi assai frequenti che ognuno ha incontrato nella sua vita. Quelle stantie signore addobbate di pellicce e attorniate da uno stuolo di graziosissimi animali, le quali non pagano la mercede alla domestica, e pure vanno a Messa tutte le domeniche e fanno anche la Santa Comunione, non sono meno irreligiose dell'ateo Lenin.
La Religione o, a dire più esatto, gli atti superstiziosi di taluni padroni, entrano nella logica del loro laicismo ateo. Dio, per loro, non esiste, d'accordo; ma se la esistenza di Dio può essere utile all'aumento delle proprie ricchezze e quindi del proprio piacere, ben venga anche la esistenza di Dio.
Non è molto consolante ma è assai significativa la definizione di Chiesa, nel senso di Tempio, tale quale un operaio l’enunciava a Jacques Valdour (Joseph Folliet, L'avénement de Promethée, Paris 1950, p. 71: «La Chiesa è una grande sala ove vanno i ricchi la domenica».
Il gioco è pericoloso, già lo notai. Gli sfruttati col nome di Dio finiranno per rifiutare una divinità che li perseguita. Nel gioco doloroso dell'alternativa succederà che essi, per la volontà di rigettare il dio ingiusto dei padroni, rigetteranno Dio. Sarà il punto d'arrivo ove il liberalcapitalismo si trasformerà nei suoi prodotti, in Comunismo ateo massacratore. Sapere quale è il destino crudele riservato ai lavoratori sotto il Comunismo, dovrebbe bastare a caricare di responsabilità il Capitalismo laicista che del Comunismo è il padre. Esso, anche se direttamente non giocasse — per pura ipotesi — alcun ruolo negativo sulla vita del lavoratore, resterebbe sempre una applicazione da evitare, quanto al Comunismo, da coloro che hanno la passione della giustizia nel campo del lavoro.
Che l'applicazione attuale del sistema Capitalista sia una frattura della umanità è d'una evidenza sconcertante. Basta affacciarsi in città per esserne colpiti. I teatri, per esempio, sono classificati a seconda della nobiltà degli spettatori: e qui nobiltà vuoi dire soltanto «portata delle tasche». Le serate di gala riservate a chi può avere l'abito di rito sono una smentita sarcastica alla uguaglianza proclamata. No e poi no; in un cinema di rione popolare la elegante Signora dell’Industriale non ci andrà mai. Ancora oltre si arriva: perfino in Chiesa la distinta (!) Signora vuole un posto a parte. Fanno puzzo di stalla quelli là, pare che dica, io non posso stare con loro. D'accordo: eccezioni ce ne sono a questo vergognoso padronale mercimonio della Religione, ma sono eccezioni: la regola è quella enunciata.
Dicevo (cfr. Il lavoro al servizio del Comunismo, p. 36) che il lavoratore nel congegno produttivo comunista altro non è che una spugna da spremere fino all'estremo e poi da buttare. Aggiungo ora che il lavoratore nel congegno produttivo del liberalcapitalismo non è nulla di più.
Allora nessuna distinzione tra situazione economica sotto il Comunismo e sotto il Liberalcapitalismo? No; ce ne sono delle differenze. Il Comunismo è essenzialmente stagnante sotto gli occhi dei Commissari politici, mentre il Liberalcapitalismo ha la leva sempre dinamica della iniziativa privata. L'iniziativa privata è spinta dalla speranza di un domani economicamente migliore. Essa scaturisce dalla leva della libera concorrenza innestata sulla rivendicazione della proprietà privata.
Taluni padroni per bene (!) si scandalizzano a sentir parlare di compartecipazione degli operai agli utili. Se gli operai vogliono migliorare la loro situazione sociale facciano economia, dicono. In verità non si penserebbe di dover trovare parole di così saggi consigli e risparmi nei salotti dei ricevimenti notturni a invito. Eppure è così. Quei tali padroni ti sanno perfino spifferare sotto il naso che Lafitte cominciò la sua ricchezza raccogliendo degli spilli, e che Edison cominciò facendo il piegatore di giornali. Come se tanto bastasse per diventare ricchi. I raccoglitori di spilli così come i piegatori di giornali si contano a migliaia; di Lafitte e di Edison ce n'è uno solo. D'altronde è ancor meno vero che i ricchi in generale abbiano costruita così la loro ricchezza. Tutti i ricchi sono ladri? No; ma tanti si.
Nemmeno priva di un certo umorismo è la mentalità dei Liberal-capitalisti occidentali. Se accade che i prestatori d'opera rivendichino una più equa divisione delle ricchezze, beh, questi Liberalcapitalisti fanno tosto ricorso alla parola «giustizia». E non s'accorgono che, avendo ateizzato le masse oltre che se stessi, tale parola diviene sinonimo di «privilegio», per i lavoratori che ascoltano. La violenza dei proletari è contro la giustizia, questo è vero. Gli è che pure l'egoismo privilegista dei padroni è contro la giustizia. Dopo tutto, in un reclusorio di atei, è anche ingenuo appellarsi alla osservanza della virtù. Avere salotti e salottini per ogni genere di ricevimenti più o meno equivoci, lasciando famiglie intere a schiacciarsi nell'angustia di una sola stanza e poi appellarsi alla giustizia legalizzante per conservare tale equilibrio è cosa almeno ridicola nel campo del ragionamento e carica di responsabilità sociali nella spinta che essa somministra alla rivolta.
L'atroce ironia sta nelle leggi strettamente economiche. A cercarvi un articolo contro il lavoratore ci si indaffarerebbe invano. Il più fuggitivo confronto con il codice del lavoro sovietico, rivela la enorme inferiorità di questo su quelli.
Un semplice raffronto
|
Costituzione dell’Unione Sovietica, ed. Unità, Roma 1945, p.,8: Articolo 6: «La terra, il sottosuolo, i boschi, le officine ecc... e così pure le aziende comunali ecc, sono proprietà dello Stato». |
Costituzione della Repubblica Italiana, Gazz. Uff. 27 dic. 1947, n. 298: Articolo 44: «Al fine di consentire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la, legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie ecc.; aiuta la, piccola e la media proprietà». |
|
Codice Sovietico del Lavoro (Matteucci, Roma 1945: Art. 11: «In casi eccezionali (la lotta contro calamità dovute agli elementi, insufficienza di mano di opera per l'esecuzione di importanti compiti dello Stato) tutti i cittadini delle RSFSR, salvo le eccezioni indicate agli articoli 12-14 potranno essere chiamati al lavoro obbligatorio in base a speciali ordinanze del Consiglio dei Commissari del popolo». |
Codice delle leggi sul lavoro (Mazzoni-Guerrieri) Bologna 1950: § 92, n. 11: «Nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale costituisce un pericolo o danno alle persone o alla produzione, il lavoro può essere prolungato al di là dei limiti dell’orario normale, purché si tratti di casi non prevedibili e non periodici e il lavoro sia indispensabile per la sicurezza delle, persone o degli impianti o per la conservazione delle materie in lavorazione. Il prolungamento di orario in tali casi dovrà essere, entro 24 ore, comunicato al competente capo Circolo d'ispezione ecc. Il capo Circolo... potrà imporre delle misure per limitare o sospendere il prolungamento dei lavori...». |
|
ART. 36: «Se, temporaneamente, non v'è nella impresa l'occasione di adibire un salariato al lavoro per il quale è stato ingaggiato, il datore di lavoro ha il diritto di destinarlo ad un altro lavoro che corrisponda alle sue abitudini. Qualora il lavoratore si rifiuti di eseguire tale lavoro, il datore di lavoro può licenziarlo dandogli una indennità di licenziamento».
Art. 37, 1: «... il rifiuto, senza giusti motivi, di accettare il trasferimento in altra fabbrica o in altra zona è considerato come infrazione alla disciplina del lavoro». |
§ 67, n. 2103: «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l'imprenditore può, in relazione alle esigenze della impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui. Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta se è a lui più vantaggioso». |
|
Art. 47, 1: «Il lavoratore che senza validi motivi, trascuri per un giorno intero di presentarsi al lavoro sarà congedato dalla impresa od istituzione». |
Costituzione Italiana, art. 40: «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano». |
|
Art. 57: «Qualora un lavoratore di una impresa, istituzione o azienda di Stato, pubblica o cooperativa, senza sua colpa non raggiunga il rendimento fissato per lui, sarà remunerato secondo la quantità e la qualità del prodotto senza che gli venga assicurato alcun minimo di salario». |
Ivi, art. 36: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa». |
|
Art. 68: «In caso di arresto del lavoro non imputabile al lavoratore il salario è pagato in misura pari alla metà...». Art. 68, 1: «I prodotti che, senza colpa del lavoratore, costituiscono uno scarto completo sono pagati in ragione di due terzi del tasso stabilito». |
Codice ecc.; § 67, n. 2102: «Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato». |
La sola lettura comparativa è tanto eloquente che mi dispensa da ogni commento.
Come sarebbe bello!
A Montreal, in Canada, il 9 Ottobre 1946 si riunivano i membri della Conferenza Internazionale del Lavoro, e proponevano alcuni emendamenti alla già esistente Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Il testo emendato comincia con questo preambolo:
«Considerato che una pace universale e durevole non può essere fondata che sulla base della giustizia sociale; considerato che esistono condizioni di lavoro che implicano, per un grande numero di persone, l'ingiustizia la miseria e le privazioni, cosa che dà origine ad una tale scontentezza che la pace e l'armonia universale ne sono messe in pericolo; e considerato che è urgente migliorare queste condizioni: per esempio in ciò che concerne la regolamentazione delle ore di lavoro, la fissazione di una durata massima..., la lotta contro la disoccupazione, la garanzia di un salario che assicuri condizioni decenti di vita...; le parti contraenti, mosse da un sentimento di giustizia e di umanità... e per ottenere gli scopi suenunciati approvano la presente Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro...». (Mazzoni-Guerrieri, Codice delle leggi sul Lavoro, Bologna 1950, p. 5-6).
La stessa Organizzazione aveva già nel 1944 (1° maggio) a Filadelfia. tenuta la sua 26a sessione in cui aveva affermato:
«La Conferenza afferma ancora una volta i principi fondamentali sui quali è fondata la Organizzazione, e specialmente:
a) il lavoro non è una merce;
b) la libertà d'espressione e d'associazione è una condizione indispensabile di un progresso sostenuto (= effettivo);
c) la povertà, dovunque essa esista, costituisce un pericolo per la prosperità di tutti;
d) la lotta contro il bisogno deve essere condotta con una infaticabile energia nel seno di ogni Nazione, e con uno sforzo internazionale continuo e concertato, nel quale i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, cooperanti su un piede di parità con quelli dei governi, partecipino a libere discussioni e a decisioni di carattere democratico con lo scopo di promuovere il bene comune».
Invece di attardarmi in enunciazioni dell'uno e dell'altro Stato Occidentale a regime Capitalista, amo continuare a scegliere alcune altre testimonianze di questa Organizzazione Internazionale. Sono parole così belle che ti prende come un nodo alla gola a leggerle mentre accanto classi intere di uomini affogano nella miseria più paurosa.
«La Conferenza Internazionale del Lavoro, il 9 Ottobre 1946, s'assumeva ancora l'obbligo di assecondare la messa in opera, fra le diverse Nazioni del mondo, di programmi atti a realizzare:
a) la pienezza dell'impiego e l'elevazione del livello di vita;
b) l'impiego dei lavoratori in occupazioni ove abbiano la soddisfazione di dare tutta la misura della loro abilità e delle loro conoscenze...;
c) per meglio raggiungere tale scopo, la messa in opera, per mezzo di garanzie adeguate per tutti gli interessati, di possibilità di formazione e di mezzi atti a facilitare le trasferte dei lavoratori, ivi comprese le migrazioni di mano d'opera e dei coloni;
d) la possibilità per tutti di una partecipazione equa ai frutti del progresso in materia di salari e di guadagni, di durata del lavoro e altre condizioni del lavoro, e un salario minimo vitale per tutti coloro che hanno un impiego e bisogno di siffatta protezione;
e) il riconoscimento effettivo del diritto di negoziazione collettiva e la cooperazione dei datori di lavoro e della mano d'opera per il miglioramento continuo della organizzazione della produzione, così come la collaborazione dei lavoratori e dei datori di lavoro all'elaborazione e alla applicazione della politica sociale ed economica;
f) l'estensione delle misure di sicurezza sociale allo scopo di assicurare una rendita di base a tutti quelli che hanno bisogno d'una tale protezione e così pure delle cure mediche complete;
g) una protezione adeguata della vita e della salute dei lavoratori in tutte le occupazioni;
h) la protezione della infanzia, e della maternità;
i) un livello adeguato di alimentazione e di alloggio e di mezzi di ricreazione e di cultura;
j) la garanzia di possibilità uguali nel campo educativo e professionale». ![]()
Commoventi parole inserite negli strumenti legislativi dei popoli occidentali a regime Capitalista. Come benefiche ondate di umanità vera su l'egoismo dei singoli. Slanci appassionati di fraternità che lasciano l'animo intenerito a pensare alla gioia festosa del mondo che si annuncia in costruzione.
Come sarebbe bello se effettivamente gli uomini responsabili della cosa pubblica fossero guidati nelle loro azioni da questi impegni ! Gli è che sembrano sogni soltanto recitati dagli angeli; la terra guidata dal liberacapitalismo pare tutta protesa verso altri obiettivi che la giustizia sociale. Spenta la eco fascinosa di quelle parole tanto umane, l'animo sconfortato s'agghiaccia a constatare l'obbrobrio dello squilibrio sociale. Si ha come paura che tutte quelle dichiarazioni non altro siano che un paravento dietro il quale, con diabolico sarcasmo, i direttori di tutta questa buffonata di cattivo gusto stiano ridendosela della credulità degli uomini che sono semplici perché sono poveri e onesti.
Viene fatto pertanto di domandarsi come mai sia possibile, con impegni sociali così umani, che ci siano tanti «paria» della vita. Allorché poi si vuol mettere sotto esame il valore umano del Liberalcapitalismo applicato più o meno negli Stati Occidentali, non bisogna lasciarsi prendere dalla mania dei confronti. Sarebbe semplicemente cieco chi volesse negare lo strapiombo che divide, per esempio, l'operaio americano dall'operaio russo, sul piano della situazione economica. Sarebbe però ugualmente cieco concludere che, dunque, il Liberalcapitalismo è la salvezza dell'operaio, che per esso l'operaio si sente veramente membro della grande famiglia umana. Il Liberalcapitalismo va giudicato in se stesso, nelle sue linee dinamiche. «Beati monoculi in terra coecorum!» (Beati coloro che hanno un solo occhio in un paese di ciechi !) è senz'altro una verità; non è però l'aspirazione di chi intende non rinunciare ad averli tutti e due gli occhi. Se la miseria dell'operaio in regime comunista è sconosciuta in America (che è il più avanzato Stato a regime liberalcapitalista), resta pur sempre vero che anche in America ci sono due classi nettamente divise economicamente: i padroni ed i servi, i datori di lavoro ed i lavoratori. E i primi vivono lautamente sul lavoro dei secondi.
Il lavoro merce produttiva
La leva delle inesauribili iniziative private, alimentate dal motore della «libera concorrenza», la messa in atto più intelligente degli attrezzi di produzione sono le due ragioni fondamentali che rendono l’economia liberalcapitalista relativamente superiore a quella comunista. «Il lavoro non è una merce» afferma l'impegno dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Mazzoni - Guerrieri, o. c., p. 44). Il lavoro però stagna sempre nel banale concetto di merce produttiva. Inutilmente si cerca nella pratica di lavoro nel Liberal-capitalismo l'elemento «persona umana». In nessuna maniera la dignità umana del lavoro e la sua funzione di affratellamento è presente. Il risultato scaturito dal lavoro di un uomo ha, sulla bilancia commerciale del Padrone, legalizzato d'altronde, lo stesso valore, lo stesso significato del medesimo risultato prodotto da uno strumento meccanico. Se per ipotesi dovesse essere così, si dovrebbe sconsolatamente concludere che per la persona umana è definitivamente finita. Pienamente d'accordo che 5.000 giornali piegati da un uomo sono la autentica cosa, commercialmente, che 5.000 giornali piegati da una macchina. Ma non si può concludere che la ricompensa a tale uomo debba consistere in un litro di benzina e in poche gocce di olio, quanto è stato consumato dalla macchina. E questo proprio perché c'è una differenza sostanziale tra il lavoro scaturito dalla persona umana e quello derivato dalle leve di una macchina.
Le illusioni e le belle parole sono inutili palliativi per nascondere la realtà: nello Stato a regime liberalcapitalista il lavoro dell’uomo è una unità matematica come tutte le altre.
Ammortizzamento
Nel gioco della produzione ha una parte diretta ed immediata il «capitale fisso». «Capitale fisso» è espressione più o meno adeguata che indica quel capitale che, nell'attività produttiva, non si consuma che lentamente. Nelle officine, per esempio, le macchine sono capitale fisso. Sono cioè un capitale che rimane un tempo indeterminato senza bisogno di essere gettato come inservibile. Ora nel sistema liberalcapitalistico del contratto di lavoro, allorché si fanno le percentuali dell'utile da distribuirsi, si porta anche una voce che riguarda il capitale fisso, cioè l'ammortizzamento. L'ammortizzamento è una operazione con la quale si preleva dal prodotto (dall'utile dividendo) una quota fissata per rimpiazzare poco a poco il capitale fisso. Oggi, ad ascoltare i competenti, le macchine delle industrie si ammortizzano nel giro di 10 (dieci) anni circa. Ogni qualvolta io ho letto qualcosa sull'argomento mi son posta una domanda: perché mai non si fa un ammortizzamento anche per l'uomo lavoratore? Analizzando gli elementi che partecipano al lavoro ci si accorge che il lavoratore oltre ad essere una persona umana è anche una macchina che si consuma. C'è dunque nell'uomo lavoratore anche un «capitale fisso» che si consuma poco a poco. Mi pare che nella determinazione del salario si dovrebbe pur tener presente anche ciò. Chiamiamola ammortizzamento di vecchiaia, se volete, questa voce nuova, ma qualcosa ci vuole. Quando il lavoratore sarà inabile al lavoro, deve avere nei suoi risparmi la possibilità di condurre una vita degna di uomo. Né mi si dica che allo scopo già ci sono gli assegni di vecchiaia od altre cose del genere. È troppo chiaro che tali voci servono soltanto a rendere appena sufficiente l'ammontare del salario per sostentare la vita giorno per giorno. Quelle voci quindi che si richiamano alla salvaguardia della vecchiaia si sciolgono nelle urgenti necessità della vita quotidiana.
Sicuro che in un sistema liberalcapitalista ove l'uomo sia considerato soltanto una macchina di produzione è difficile trovar posto per questa nuova voce in favore del lavoratore: il suo avvenire infatti di inabile non interesserà più la fabbrica, ove, tuttavia, egli ha logorata anche la sua macchina (corpo). Il lavoratore non è soltanto una macchina (corpo), già lo notai altrove; ma esso è certamente anche una macchina che si logora lentamente e che pertanto dà a colui cui appartiene il diritto ad una quota di ammortizzamento almeno pari a quella per un qualunque capitale fìsso.
Dunque nel bilancio di ogni impresa, l'attuale lista che contiene le cinque voci seguenti: a) acquisti d'ogni genere; b) imposte; m) ammortizzamento del capitale fisso; rc) rimunerazione del capitale (cioè del padrone del capitale); rl) rimunerazione del lavoratore (salario), io penso che dovrà arricchirsi di una nuova voce e cioè: ml) ammortizzamento del lavoratore. Mi pare che ignorare ciò significhi voler restare in uno stato di squilibrata divisione degli utili in favore del capitale a scapito del lavoratore.
D'altra parte ci si accorge presto, ad un esame reale, che il sistema capitalistico porta in sè un germe costante di marcia verso la ingiustizia. Direi che l'economia capitalistica corre su di un piano inclinato ai margini del quale l'attende l'ingiustizia. Per esser chiari nella esemplificazione supponiamo che l'utile da dividersi tra datore di lavoro e lavoratore sia fissato nella proporzione del 70% per il lavoratore e del 30% per il datore di lavoro. Traducendo il contratto in un caso pratico supponiamo che l'utile da dividersi sia rappresentato da L. 1000. Secondo il contratto suaccennato la divisione corrisponderà 700 al lavoratore e 300 al datore di lavoro. E cioè indicando con U l'utile, con L ciò che spetta al lavoratore, e con P ciò che spetta al padrone noi avremo la seguente proporzione:
Il lavoratore però si mangerà il suo misero salario nelle urgenti necessità della vita quotidiana, mentre il datore di lavoro potrà investire quel suo 300 in migliorie al capitale fisso, aumentando così il prodotto e quindi anche l'utile. Il salario dal lavoratore resterà tuttavia quello fissato di 700. Siccome però l’utile dividendo dopo le migliorie non sarà più 1000 ma sarà passato, supponiamo, a 1010, ferme restando le settecento lire del lavoratore, la proporzione iniziale del 70% al lavoratore e del 30% al datore di lavoro si sarà automaticamente trasformata nella seguente: 69,306% al lavoratore e 30,694% al datore di lavoro. Le 1010 lire da dividersi infatti saranno ripartite così:
Se si esclude ogni correttivo che scaturisca dalla rettitudine individuale di ogni datore di lavoro, si arriva, in astratto, alla realizzazione sistematica di uno slittamento continuo delle proporzioni percentuali dell'utile a vantaggio del capitale e a danno del lavoratore.
Gioco d'altronde assai logico, dirà il Capitalista (e con lui la legge), poiché l'aumento dell'utile da 1000 a 1010 e successivamente, deriva dalle migliorie apportate al capitale fisso per mezzo di danaro che era del padrone. Argomentazione inesatta invero, perché il capitale fisso migliorato col danaro del padrone è però fatto produrre dal lavoratore, il quale partecipa pertanto direttamente alla produzione dell'utile 1010 e non più alla sola produzione dell'utile 1000. Certo non per lo spostamento da 1000 a 1010 si parlerà di ingiustizia superveniente nel contratto di lavoro; tale ingiustizia però diverrà reale e anche palese allorché le migliorie permetteranno, per ipotesi, di raddoppiare la produzione. Facciamola la ipotesi di una fabbrica che raddoppia la sua produzione. La Fabbrica ANIMETTI ha una data produzione; il suo bilancio comprende normalmente le voci seguenti: a) acquisti di ogni genere; i) imposte; m) ammortizzamento del capitale; rc) rimunerazione del capitale; rl) rimunerazione del lavoratore. Indicando con F la fattura completa noi abbiamo dunque:
Supponendo ora che la produzione raddoppi indichiamo le voci con a' + i' + m' + rc' + rl', cosicché avremo:
Per amore di semplificazione supponiamo ora che nel raddoppiamento della produzione raddoppino anche gli acquisti e le imposte (ciò che non è sempre vero), cioè il passivo diretto. Va subito notato che a produzione raddoppiata, pure ammettendo anche il raddoppiamento delle spese dirette, dovrà corrispondere anche il raddoppiamento delle altre voci. Dovremo cioè ottenere che m’ + rc’ + rl' equivalga effettivamente al doppio, e cioè m' + rc' + rl' deve essere uguale a 2 (m + rc + rl). Gli è che nel caso supposto i salari resteranno sempre quelli già fissati nel contratto di lavoro; resteranno fissi, e in realtà noi avremo che rl' sarà uguale a rl. Il di più del dividendo m' rc' rl' sarà in realtà diviso solo fra m' e rc'. La formula effettiva sarà quindi diversa da quella che dovrebbe essere. Invece di m'+ rc' + rl' = 2 (m + rc + rl) avremo la seguente:
Tale formula dimostra che ciò che sarà dato in più a m ed rc sarà costituito da un'altra quota m + rc più anche la quota rl che non viene passata al lavoratore, poiché il salario resta sempre fisso. Slittamento evidentissimo dell'utile a vantaggio del solo datore di lavoro; slittamento legato alla natura stessa del Capitalismo qualora non ci sia un fattore di onestà umana il quale basti a correggere questo squilibrio sempre rinascente. Lo slittamento diventa chiarissimo se noi diamo un valore alle lettere. Per esempio, nel caso precedente, diamo alle lettere il valore seguente:
Notando che m e rc rappresentano la parte che va al padrone, avremo 17 per lui, e cioè m + rc = 9 + 8. Raddoppiando la produzione il padrone dovrebbe ricevere 2 (9 + 8) = 2 x 17 = 34, mentre in realtà esso — i salari restando fissi — riceverà 34 più un 37, che è poi quel 37 che normalmente dovrebbe andare al lavoratore come raddoppiamento del suo salario in ragione del raddoppiamento della produzione. Indicando con m + rc ciò che sarà passato al padrone, la formula giusta:
verrà invece modificata nella sua applicazione e diventerà:
Tutto questo perché il salario è stabile e non segue la curva ascendente della produzione. D'accordo che questa è una supposizione del tutto teoretica; essa dimostra però le possibili deviazioni inerenti al sistema capitalistico. Ogni Stato ha naturalmente cercato di apportare taluni correttivi, tra i quali il più provvido è quello del salario «proporzionale». In effetti però il salario dei lavoratori è «fissato» e non cresce col crescere dei profitti. Nella migliore delle ipotesi esso verrà adeguato, ma in un tempo senz'altro successivo; dopo cioè che il padrone avrà già ricavato un certo vantaggio dallo squilibrio della divisione degli utili. Né si obbietti che, allora, il salario dovrebbe diminuire nel caso di produzione diminuita. Prima di tutto, in caso di produzione diminuita, volendo abbassare il salario del lavoratore gli si toglierebbe ciò che costituisce per lui un elemento necessario di vita, mentre caricando tutta la perdita sulle entrate del padrone ci si limiterebbe a ridurne l'arricchimento. Ora in nome della dignità dell'uomo, si capisce facilmente che nella ipotetica necessità di operare una sottrazione, essa deve operarsi su di un genere soltanto utile, piuttosto che su di un genere che è assolutamente necessario. Senza dire poi che nel caso di diminuzione della produzione, o il fenomeno è momentaneo e allora lo si rimedierà appresso, o è fenomeno costante, e in tale eventualità la fabbrica si chiude. È inutile farsi delle illusioni: un padrone non tiene in vita una fabbrica che sia in costante rimessa.