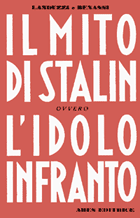Atto primo - scena prima
 |
 |
C'era un altare
L'idolo
|
«Questa notte Giuseppe Stalin è morto, e difficile è a me parlare, sig. Presidente. L'animo è oppresso dall'angoscia, per la scomparsa dell'uomo più che tutti gli altri venerato e amato, per la perdita del maestro, del compagno, dell'amico» .
(dal discorso pronunciato in Parlamento da Palmìro Togliatti il 6 marzo 1953)
|
C'era proprio come un altare nell'arcata del portico a Sassuolo (e in tanti altri paesi); e i ceri ardevano sul drappeggio rosso tutto attorno e il ritratto dell'uomo Stalin pareva sorridesse. La gente, tanta gente, piangeva. I primi colloqui che avemmo con taluni compagni della base mettevano a nudo il profondo reale dolore per la scomparsa del loro uomo.
Accanto all'altarino c'era un quadernetto semplice e spaurito: aveva il compito di raccogliere le firme di coloro che credevano in lui. La gente della base piangeva: un cordoglio sincero scaturito forse dalla suggestione nata e alimentata dai discorsi piazzaioli degli attivisti. I quali non piangevano. Il pianto non si addice ai forti capi dei rossi. La incertezza dell'avvenire, però, scavava sui loro volti profonde rughe di amarezza cupa e malamente presaga. E noi?
Veramente anche noi, in quei giorni, abbiamo pensato a lui: la mente fissata sull'incontro di quell'anima con Dio. E serio era anche il nostro volto; dinanzi ai nostri occhi sfilavano le ombre di milioni di assassinati: perché lui aveva ordinato così. La strage dei contadini e quella degli ufficiali, la persecuzione dei cristiani ed il massacro dei collaboratori od antagonisti. Ci ricordammo dei nostri prigionieri barbaramente trucidati, delle foibe rosse, delle fosse di Katin, delle mamme italiane imploranti da lui la restituzione o almeno la indicazione dei resti dei figli.
Eravamo un po' tutti costernati: per ragioni diverse.
C'erano — è doveroso ricordarlo — anche delle voci imprecanti: forse i figli di gente assassinata in suo nome.
E in Italia?
Noi sentivamo pesare, in ultima istanza, sulla sua umana coscienza anche i nostri ragazzi assassinati qui da noi, dietro il suo insegnamento. Pensammo a Gervasio Federici, a Giuseppe Fanin e alle decine di giovani e di sacerdoti massacrati per lui: vittime per il dio (dicevano proprio così) Stalin.
Povera fine di un uomo scellerato.
A Roma, nel '49-50 avevamo visitato la mostra dei doni a papà Stalin, organizzata dai nostri compagni. Partecipammo alle manifestazioni di piazza. Seguimmo la stampa comunista internazionale e quella italiana. Un coro uniforme di voci osannanti alla prodigiosa intelligenza, alla magistrale fierezza dottrinale sul marxismo-leninismo, alla chiaroveggenza politica, alla modestia umana del grande scomparso. Sulla sua tomba, sentimmo e leggemmo sgorgare spontaneo nel cuore di tutti i lavoratori e compagni un giuramento di incrollabile fedeltà all'insegnamento marxista di lui e alle direttive.
Tutte le strade d'Italia e le cellule erano diventate come un vastissimo tempio della nuova religione rossa. E le parole umane parvero insufficienti, ai pontefici del nuovo rito, a descrivere la grandezza del «padre dei popoli» , come lo chiamavano.
E si scrisse: «Gloria eterna a Stalin!»