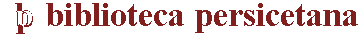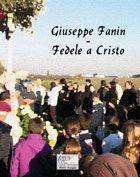Fanin e i cattolici
 |
 |
Visto in un quadro europeo, Giuseppe Fanin è uno dei tanti che, impegnato nella azione sociale e sindacale, è stato vittima della violenza delle forze totalitarie. Anche solo a guardare alla nostra regione, statisticamente il suo è uno fra i nomi. Ma, nella percezione del tempo, il suo caso fu sentito in modo straordinario e, tutto sommato, unico; lo testimoniano quanti vissero quei giorni, o parteciparono ai funerali e, naturalmente, la stampa e le cronache. Certo: Fanin era già un punto di riferimento per l’intera provincia; era impegnato in più direzioni, dalla AC all’azione sociale al sindacato; il momento era caratterizzato da eccezionali tensioni, e certi fatti si notavano maggiormente. In fondo, erano passati solo tre anni dalla fine della guerra e, nelle nostre zone, le tragedie della guerra erano ancora attuali. Il suo assassinio apparve il culmine di una strategia di violenza, e, in qualche modo, la situazione apparve non più sopportabile. Sono tutti motivi che spiegano, in parte, questo effetto di amplificazione e di partecipazione corale. Ma c’è dell’altro, e non è così semplice delinearlo. Non ci interessa qui affrontare il tema, che sarebbe tutto da documentare, delle reazioni di allora e in seguito, delle varie parti dello schieramento politico. Ci basta riflettere su ciò che Giuseppe Fanin ha rappresentato, allora e poi, per i cattolici, in particolare per quelli impegnati nell’azione sociale; non solo allora, nell’emozione del momento, ma negli anni, pure nell’allontanarsi via via dai fatti e nello scomparire, poco per volta, di gran parte dei testimoni.
Fanin divenne immediatamente un simbolo. La sua personalità, il suo impegno, vennero presentati da quanti l’avevano conosciuto ed erano stati testimoni della vicenda, in molteplici occasioni, celebrative e di formazione. La data della sua morte (del suo “martirio”) divenne subito una ricorrenza da ricordare stabilmente, con cerimonie religiose e civili.
L’allontanarsi del fatto non ha provocato una diminuzione di questa attenzione; anche perché, al di là di altri aspetti di carattere politico, ogni anno le iniziative promosse aggiungevano motivi di riflessione e aiutavano a mettere in luce elementi prima non considerati. Certo i cambiamenti sociali hanno avuto il loro peso, in questo come in altri casi, nel cambiare sensibilità e prospettive: dalla drastica diminuzione dei lavoratori della terra, passati dal 48 al 6%, al nuovo benessere, propiziato dagli aiuti americani e reso possibile dall’istituzione delle Comunità; dall’evoluzione sociale, morale, di sensibilità politica, manifestatasi particolarmente dopo la metà degli anni sessanta, alla crisi internazionale del movimento dei lavoratori, tradottasi in Italia nelle scelte di “autonomia” delle associazioni di lavoratori, nella ricerca di convergenze con il mondo socialista, o nelle “comunità di base” contrapposte alla “Chiesa gerarchica”.
In questi anni difficili, Fanin ha continuato ad essere presente come modello di integrità e di coerenza, esempio di un giovane per i giovani, occasione di meditazione per gli adulti. È naturale che venisse sottolineata la sua volontà di sposarsi, costituire una famiglia, avere dei figli, e la capacità di vedere tutto questo in armonia con la decisione, altrettanto forte, di impegnarsi per il miglioramento del mondo contadino, elaborando proposte criticamente fondate e operativamente costruttive; insistendo sulla effettiva partecipazione di tutti e nel benessere per tutti, secondo la più genuina tradizione cooperativa. È logico che si notasse in lui la piena corrispondenza tra vita di fede e impegno sociale e civile; dove la fede, anche nella lettura del magistero e nella conoscenza della storia dell’azione cattolica, era essa stessa motivazione all’impegno, mentre forniva una adeguata antropologia; evitando così le assolutizzazioni proprie delle ideologie e dei sistemi totalitari, la ricerca del cambiamento immediato e completo, imposto con la forza.
La frammentazione della Chiesa nel suo insieme, delle organizzazioni cattoliche in particolare (tutte, nessuna esclusa: dalla AC agli scouts), la rilettura della storia lontana e vicina alla luce delle ideologie, hanno reso più difficile la sua comprensione; hanno soprattutto rischiato di fare collocare la sua vicenda nel novero dei fatti “che sono successi”, ma che non ci coinvolgono. Non è casuale che il card. Biffi abbia voluto ricordare che la Chiesa “celebra i martiri”, non “ricorda i persecutori”; il che non significa che lo storico - anche quello che si occupa, come è stato in questo caso, delle cause dei santi - non debba richiamare l’attenzione sui persecutori; ma che l’intento ecclesiale è quello di mettere in luce le virtù da imitare, ed è secondario, da questo punto di vista, chi sia stato la causa del martirio.
In una Causa, il “consensus Ecclesiae”, il sentire dei fedeli, è elemento primario; tale sentire si manifestò subito, alla scomparsa; si è mantenuto ed approfondito. È quindi indubbio, come si diceva all’inizio, che in lui la Chiesa (i fedeli) abbia avvertito qualcosa del tutto particolare; anche le iniziative promosse in vista del sessantesimo lo hanno confermato.
Ricordare una figura, per quanto straordinaria, non è un obbligo; sarebbe tuttavia un peccato se, per mancanza di impegno, per le circostanze del tempo, soprattutto per il profondo cambiamento operatosi nella Chiesa e nella società, esempi come questo non venissero fatti conoscere alle nuove generazioni. Nella dispersione attuale (si parlò già di società “consumistica”; ma quella era solo la premessa) è certo difficile parlare di quei tempi; di dedizione, di sacrificio; perfino di responsabilità per la famiglia futura; anche se queste caratteristiche sono a tutt’oggi presenti in altre parti del mondo e se il martirio è realtà sempre attuale. È difficile parlare di Fanin in una società protesa al godimento balneare; nella quale il termine “responsabilità” è inesistente, lo studio è una necessità priva di senso, il lavoro è solo un modo di acquisire denaro; aggiungo: in una sensibilità ecclesiale nella quale spesso il magistero è un oggetto misterioso, la formazione è solo stare insieme e “volersi bene”, e ognuno può pensare a fare “in coscienza” quello che vuole. Eppure, anzi, forse a maggior ragione, vale la pena di parlarne. Ogni società vive di punti di riferimento: o se ne offrono di validi, o se li creerà da sola. Non vale la pena esemplificare. Nel mutare dei tempi e della sensibilità, la figura di Giuseppe Fanin, che in questi decenni non solo si è mantenuta presente, ma, anzi, è venuta crescendo dal lato dei riconoscimenti civili (intitolazione di strade, es.), corre il rischio di restare patrimonio di una élite. Proprio la crescita di spessore della sua immagine, grazie alle tante riflessioni e agli studi, rischia di renderlo difficile non solo ai più giovani, ma agli adulti di oggi.
La Causa, come è noto, è stata completata in Diocesi, e gli Atti sono stati trasmessi a Roma. È possibile che nella sede competente si dia parere favorevole a quanto presentato, e Fanin venga riconosciuto uno dei (tanti) martiri del XX secolo. Ma, al di là di questo, “Dio ha bisogno degli uomini”. Come il suo ricordo durante questi sessanta anni è derivato certo dalla sua figura come tale, ma, insieme, dalla testimonianza di tanti; così, oggi e in futuro, la luminosità della sua persona sarà affidata sì a se stessa, ma anche all’azione di quanti la apprezzano; quindi, alle occasioni che si cercheranno di farla conoscere, a cominciare dai giovani e giovanissimi.
Dovrei dire: dipenderà dalla volontà di “imitarla”; perché l’imitazione, il “fare lo stesso”, è sempre stato, ed è, l’essenza della proposta di santità. Ma, di questo, oggi come in passato, ognuno prenda ciò che è in grado di accogliere.
Bologna, luglio 2008